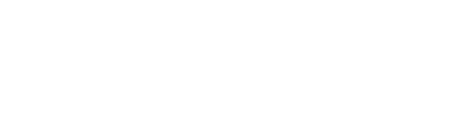INCONTRO CON L’ARTISTA. CARENA, LA PELLE AZZURRA
Gazzetta del Popolo, 9 gennaio 1980
Veste lo sguardo d’azzurro. Allunga la vista verso l’alto. Affonda la sua lampada nell’aria. Rischiara le nubi e le disegna in competizione con il vento. Antonio Carena è pittore di cieli. Lo è da vent’anni. Cieli italici, da cartolina illustrata, catalogo viaggi, programma vacanze.
La gente con i suoi quadri appende il sereno alle pareti di casa. Una piastra patinata d’azzurro per bloccare finestre: chiudere gli occhi sul mondo, balzare su tele carrozzate spider.
Carena mette nel gioco della sua pittura quella qualità intellettuale (definita da Empedocle con la parola metis) che conferisce all’artista l’abilità quasi magica di trarre dalla materia inerte dei colori «figure cangianti, variegate, vive», per cui il migliore tra i pittori «sarà colui che inganna facendo le cose simili al vero». Il «neo-verismo» di Carena però è doppiamente ingannevole perché opera non soltanto sulla vista, ma sui valori simbolici. Il pittore, con una punta sottile di perfidia, confessa di non amare il cielo, «l’ho scelto perché è la pelle più delicata che conosco», una pelle pulita, ecologicamente incontaminata, sbattuta sul perbenismo oleoso dei microsistemi economici. Un azzurro «carenato» che buca i muri delle tane, che sfonda le banalità del quotidiano. Una lama rivestita di sdolcinata tenerezza, ingannevole, si diceva, perché accordabile con le fodere dei divani. Quando Carena accenna ai problemi del suo lavoro non si nasconde dietro i grandi temi dogmatici dell’arte. Sa che l’arte è mestiere di uomo libero, ma mestiere soggetto alle più comuni e banali leggi di mercato: «l’artista, se ha fortuna, nella nostra società non è altro che un impiegato del pensiero. Ma come individuo è sconfitto».
«Nella nostra società egli (artista) deve trovarsi una collocazione per essere immediatamente «identificato” deve cioè impossessarsi di una sigla per poter allargare il proprio pensiero».
Carena parla in scioltezza. Ma, a tratti, un velo scende sulla sua intelligente perfidia. Non dichiara, ma sembra suggerire nuovi tagli d’interpetazione: i margini del quadro diventano perimetro di una botola senza via d’uscita. L’uomo vi precipita e si aggrappa con lo sguardo a quell’ultimo (unico) cielo.
Eppure c’è anche molta umiltà nelle parole di Antonio Carena («io sto poco volentieri con i pittori, perché quasi tutti si credono dei geni… attaccano le strutture, ma poi vedi che ci stanno bene dentro»), in casa sua non sono esposti che lavori di altri artisti (Fontana, Man Ray, Duchamp, Christo, Klein, Cesar, Arman per citarne alcuni): «è necessario saper leggere il lavoro degli altri e vedere le cose dal “vivo”. Ho capito e imparato da Klein, perché ho potuto studiare le sue prime opere esposte in una galleria di Milano».
Il lavoro è dunque un fatto importante.
«Non ci sono molte cose in cui credere, ma nel proprio lavoro sì, si può credere. L’arte però si scopre solo se si è disposti a pagare un prezzo molto alto: natali e pasque sempre giù a lavorare»”.
«Al Liceo Artistico, dove insegno, cerco di parlare ai ragazzi facendo attenzione di mantenere ben saldi i piedi per terra. Se intuisco che gli studenti per capire hanno bisogno dei fumetti, allora sotto con i fumetti. Io non discuto i linguaggi, cerco invece di controllare i contenuti, badando al “cosa” si dice».
«Il mio lavoro non vuole essere altro che un segnale in questa direzione. Quando scrivo che il cielo non esiste, che è una mia invenzione, intendo dire che attraverso questa sigla si possono anche esprimere umore e sentimenti e che la muta poesia delle immagini non può soffocare l’urlo di certi momenti. Quando è morto Pasolini, per esempio: tre cieli in una sola mattinata ho dipinto, tre cieli neri, una scritta, una data, un colpo di spugna …. Carena ha un attimo di incertezza, quasi di pudore: «lo so, l’arte è un’arma talmente spuntata che non servirà mai per fare le rivoluzioni» .
E a chi serve dunque?
«Serve a chi la pratica e anche agli altri per capire le proprie contraddizioni. Credo di essere stato abbastanza fedele a queste piccole tesi dal giorno stesso (eravamo nel 1951) che ho dipinto a grandi lettere la mia data di nascita. All’Accademia di Belle Arti, Paolucci, del quale ero allievo, mi diceva «Guarda i senesi, guarda i senesi… » e io gli risposi con questo quadro. Potrà sembrare strano e forse incoerente, ma la mia idea di lavoro è rimasta sempre quella».
Si tratta di un’opera molto insolita, che ha già le misure standard di quasi tutti i lavori di Carena (un metro per un metro). La data di nascita dell’artista («29.4.935») che è anche l’ovvio tititolo del quadro, occupa quasi tutta la superficie pittorica. Una scritta nera, rabbiosa, incastrata tra l’osservatore e il cielo (che filtra appena, attraverso i segni), un soggetto-oggetto assurdo (pensiamo un attimo a che cosa si produceva in questi anni in Italia e in Europa ) che prefigurava, forse inconsciamente (ma in quale misura?) tutta una serie di «vene» artistiche che ancora oggi «tengono» assieme buona parte dei mercati, un’intuizione fulminante che la critica ha chiuso nell’armadio, ma di cui non potrà sbarazzarsi tanto facilmente.
Ma allora questa pittura?…
«Dipingo per bell’umore. Una danza. Se mi venisse a mancare l’applauso, abbandonerei il palcoscenico. Immediatamente»